Lucinda
Williams
Americana
Woman | | | |
Album di famiglia: un viaggio nell'archivio di RootsHighway.
La discografia di Lucinda Williams negli anni 2001-2014
Sulle ali dell'entusiasmo
per la pubblicazione del doppio, monumentale
When
the Spirit Meets the Bone,
disco in grado di definire un'intera carriera,
il nome di Lucinda Williams è
tornato prepotentemente al centro della cosidetta
scena Americana. Anzi, ha reclamato una volta
di più lo scettro di regina, perché
in verità non era mai stata spodestata.
Superati i sessant'anni, l'autrice di Lake
Charles, Louisiana rappresenta una sorta di
archetipo per il genere, pilastro sul quale
poggia il suono e la scrittura di molte artiste
venute dopo di lei.
E' innegabile infatti che il corpo
di canzoni - spesso incentrate su affetti, malinconie, ricordi e naturalmente
abbandoni e morte - sviluppato a partire dal suo grande successo con Car Wheels
on a Gravel Road (1998) sia ancora oggi un tema di confronto per qualsiasi
nuova voce femminile intenda giocare la sua partita in questo campo. Forse una
sfida persa in partenza, a giudicare dalla solidità della discografia della
Williams, seppure tra alti e bassi, negli ultimi quindici anni. Ripercorriamo
allora un piccolo album di famiglia di recensioni, così come quei suddetti
dischi sono stati accolti al momento della loro uscita sulle pagine di RootsHighway.
Ci si accorge una volta di più come, caratteristica soltanto di alcuni
grandi autori, Lucinda Williams non abbia mai veramente cambiato il suo modo di
scrivere, eppure sia riuscita spesso a trovare uno spunto diverso di album in
album: ora affidandosi a nuovi musicisti, ora a diversi produttori, mantenendo
saldo il cuore del songwriting.
Il punto di svolta naturalmente è
stato il citato Car Wheels, non perché preceduto da opere meno importanti
(la maturità dell'omonimo
del 1988 o il successivo Sweet Old World, gli esordi addirittura alla fine
degli anni 70, con le incisoni folk per la Smithsonian), semmai per l'intuizione
di avere trovato una espressività completamente originale eppure classica,
che nelle tappe successive non ha fatto altro che maturare da quel canovaccio.
Sei lunghi anni di gestazione, una creazione sofferta e l'inatteso successo hanno
reso Car Wheels un preciso spartiacque: da allora infatti è arrivato il
vero e proprio riconoscimento, una certa indipendenza, che le ha permesso di realizzare
le sue idee, anche attraverso avventure discografiche non semplici, prove d'orchestra,
dovremmo dire, che ne hanno dilatato il suono originariamente roots. Fatto sta
che, dal controverso Essence, passando per l'ambizioso West, fino al recentissimo
When the Spirit Meets the Bone, Lucinda Williams ha lacerato la sua anima
di rockeuse e tormentata folksinger, indicando la strada. Impervia, dura, piena
di saliscendi dell'anima. - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
 Essence [Lost Highway 2001]
Essence [Lost Highway 2001]
di Stefano
Hourria
 Veniva
da un capolavoro, Lucinda Williams, da quel Car Wheels On The Gravel Road
che resta il suo disco migliore e uno dei più belli in assoluto degli ultimi vent'anni.
Sarebbe stato difficile ripetersi allo stesso livello e d'altra parte nessuno,
a partire dalla stessa Lucinda Williams, avrebbe voluto ripetere il percorso ad
ostacoli che portò, una volta arrivati in fondo, a Car Wheels On The Gravel Road.
Essence, pur mantenendo la cifra del songwriting e dell'interpretazione
di Lucinda Williams (che da allora si è ripetuta, inalterata, a livelli sempre
ottimi) è stato frutto di scelte più intimiste e di suoni più ricercati ma meno
complicati da mettere insieme di una rock'n'roll band. Una grossa responsabilità
(e una bella fetta di merito) spetta a Charlie Sexton, un musicista con una visione
molto articolata dei suoni e delle canzoni. Essence non è la sua produzione migliore
(ad oggi il posto d'onore tocca al gran lavoro fatto per Join The Parade di Marc
Cohn), ma paradossalmente infonde al disco e alla stessa Lucinda Williams una
patina di originalità rimasta unica. Veniva
da un capolavoro, Lucinda Williams, da quel Car Wheels On The Gravel Road
che resta il suo disco migliore e uno dei più belli in assoluto degli ultimi vent'anni.
Sarebbe stato difficile ripetersi allo stesso livello e d'altra parte nessuno,
a partire dalla stessa Lucinda Williams, avrebbe voluto ripetere il percorso ad
ostacoli che portò, una volta arrivati in fondo, a Car Wheels On The Gravel Road.
Essence, pur mantenendo la cifra del songwriting e dell'interpretazione
di Lucinda Williams (che da allora si è ripetuta, inalterata, a livelli sempre
ottimi) è stato frutto di scelte più intimiste e di suoni più ricercati ma meno
complicati da mettere insieme di una rock'n'roll band. Una grossa responsabilità
(e una bella fetta di merito) spetta a Charlie Sexton, un musicista con una visione
molto articolata dei suoni e delle canzoni. Essence non è la sua produzione migliore
(ad oggi il posto d'onore tocca al gran lavoro fatto per Join The Parade di Marc
Cohn), ma paradossalmente infonde al disco e alla stessa Lucinda Williams una
patina di originalità rimasta unica.
Se lo si guarda in retrospettiva,
Essence è un capitolo speciale nella sua discografia (World Without Gravity, Little
Honey sono molto più legati a Car Wheels On The Gravel Road che ad Essence; forse
è West quello che gli si avvicina di più) con quel suono rarefatto e stratificato
che Charlie Sexton ha organizzato attorno alle tracce iniziali che Lucinda Williams
incise con Bo Ramsey. Non è l'unico a seguirla da vicino, visto che gli altri
musicisti coinvolti sono Jim Keltner, Tony Garnier, David Mansfield, Jim Lauderdale,
Reese Wynans, Gary Louris. Tutti nomi ben conosciuti che garantiscono gli effetti
voluti da Charlie Sexton: atmosfera, profondità, tensione. Con una maniacale cura
del dettaglio, molte idee, una grande selezione di canzoni (da Lonely
Girls a Broken Butterflies) e un
"paesaggio" sonoro affascinante, Essence è un disco da riscoprire e da coltivare
con pazienza e scrupolo, così come è stato composto (e dopo Car Wheels non si
poteva fare di più).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 World Without Tears [Lost Highway 2003]
World Without Tears [Lost Highway 2003]
di
Fabio Cerbone
 Lucinda
Williams è una donna molto coraggiosa: non ci sono calcoli nelle sue canzoni,
è tutto così vero, spoglio e crudo da fa pensare a una artista assolutamente pura.
World Without Tears nasce sotto il segno di queste considerazioni,
tanto è sincera e trasparente la musica che contiene. Non ama mediazioni la nostra
Lucinda e sarà per questo che oggi nessuno, ma proprio nessuno, riesce a cantare
l'amore come lo fa lei, mettendo a nudo i suoi sentimenti, raccontando storie
che hanno in bocca il sapore amaro delle delusioni, dei tradimenti e della sofferenza,
ma anche del riscatto. Tematicamente è una sorta di prosecuzione del tormentato
Essence, magnifico disco in cui le sue radici sudiste ed il sound tipicamente
roots e coriaceo degli esordi si trasfigurava in qualcosa di assolutamente originale,
un ciondolante folk-rock dall'aria desolata, che catturava solo sulla lunga distanza.
Il nuovo corso riprende esattamente da quelle certezze, anche se prova di nuovo
a spingersi in avanti, a cambiare le regole del gioco. E' per questo che la Williams
ha coraggio da vendere: questa volta tocca alla produzione di Marc Howard rendere
affascinante il percorso, con arragiamenti secchi e dichiaratamente "live", la
voce in primo piano ed una band ridotta all'essenza del rock'n'roll (chitarra,
basso, batteria e siamo già pronti). Lucinda
Williams è una donna molto coraggiosa: non ci sono calcoli nelle sue canzoni,
è tutto così vero, spoglio e crudo da fa pensare a una artista assolutamente pura.
World Without Tears nasce sotto il segno di queste considerazioni,
tanto è sincera e trasparente la musica che contiene. Non ama mediazioni la nostra
Lucinda e sarà per questo che oggi nessuno, ma proprio nessuno, riesce a cantare
l'amore come lo fa lei, mettendo a nudo i suoi sentimenti, raccontando storie
che hanno in bocca il sapore amaro delle delusioni, dei tradimenti e della sofferenza,
ma anche del riscatto. Tematicamente è una sorta di prosecuzione del tormentato
Essence, magnifico disco in cui le sue radici sudiste ed il sound tipicamente
roots e coriaceo degli esordi si trasfigurava in qualcosa di assolutamente originale,
un ciondolante folk-rock dall'aria desolata, che catturava solo sulla lunga distanza.
Il nuovo corso riprende esattamente da quelle certezze, anche se prova di nuovo
a spingersi in avanti, a cambiare le regole del gioco. E' per questo che la Williams
ha coraggio da vendere: questa volta tocca alla produzione di Marc Howard rendere
affascinante il percorso, con arragiamenti secchi e dichiaratamente "live", la
voce in primo piano ed una band ridotta all'essenza del rock'n'roll (chitarra,
basso, batteria e siamo già pronti).
Anche per questo World Without Tears
non sarà un ascolto facile: nei testi è sempre la stessa Lucinda che abbiamo imparato
ad amare, fragile e forte al tempo stesso, ma l'impianto sonoro richiede uno sforzo
in più. Il soffio country di Overtime e quello
più soul della stessa title-track, ballate come Ventura o Minneapolis
fanno tutte parte del suo bagaglio di esperienze passate, ma nei ritmi sghembi
di Righteously e American Dream, nel
talkin' incalzante di Sweet Side ci sono scelte
davvero spiazzanti, che ribadiscono l'ispirazione di questa grande artista. Chi
vorrà poi assaggiare le sberle elettriche della band (con una menzione per Doug
Pettibone alle chitarre) troverà pane per i propri denti nel bluesaccio torbido
di Atonement, in cui la voce si trasforma in un ringhioso lamento, e nel
fragoroso rock'n'roll di Real Live Bleeding Fingers and
Broken Guitars Strings, monumento agli Stones dei settanta e ai riff
di Keith Richards. Il motto recita: "un artista di cui si è perso lo stampo"
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
 Live @ the Fillmore [Lost Highway 2005]
Live @ the Fillmore [Lost Highway 2005]
di
Gianfranco Callieri
 A
Lucinda Williams non è mai piaciuto fare le cose in fretta. O forse non ha mai
potuto, chissà. Anche adesso, oltrepassata la boa dei 50 anni nonché raggiunto
uno status artistico e commerciale di tutto rispetto, la nostra rockeuse preferita
non sembra intenzionata a farsi abbindolare dalle sirene della serialità o dei
dischi un tanto al chilo. In parte, questa ragionata lentezza nel cadenzare le
uscite discografiche è da imputarsi alle sue origini sudiste (è nata a Lake Charles,
Louisiana, nel 1953) e al carattere rilassato e sornione che paiono portare in
dote; in parte, e secondo me nella parte sostanziale, la carriera di Lucinda è
stata sempre contrassegnata da un approccio assai incisivo alla sala d'incisione:
un lavoro - Fruits Of My Labor - di meticolosa, paziente e testarda professionalità
che, album dopo album, le ha consentito di cucirsi addosso un suono personalissimo
e immediatamente riconoscibile, quello poi estrinsecatosi in tre dischi - Car
Wheels On A Gravel Road, Essence), World Without Tears - a dir poco perfetti sotto
ogni possibile profilo. Non che quelli precedenti si segnalassero per demeriti
particolari, ma alla luce dell'inattaccabile equilibrio degli ultimi lavori è
naturale identificare i più stagionati Ramblin' ('78), Happy Woman Blues ('80),
Lucinda Williams ('89) e Sweet Old World ('92) nelle prove generali, talvolta
istintive e talvolta sofferte, di una visione che avrebbe trovato pieno compimento
soltanto in seguito. Logico, insomma, che giungesse il fatidico doppio dal vivo
a fotografare, celebrare e suggellare un lustro abbondante di ispirazione inesausta,
e Live @ The Fillmore non delude certo le aspettative, marchiando
anzi la stagione discografica in modo indelebile attraverso un trionfo di rabbia,
dolcezza, passione e rock'n'roll. A
Lucinda Williams non è mai piaciuto fare le cose in fretta. O forse non ha mai
potuto, chissà. Anche adesso, oltrepassata la boa dei 50 anni nonché raggiunto
uno status artistico e commerciale di tutto rispetto, la nostra rockeuse preferita
non sembra intenzionata a farsi abbindolare dalle sirene della serialità o dei
dischi un tanto al chilo. In parte, questa ragionata lentezza nel cadenzare le
uscite discografiche è da imputarsi alle sue origini sudiste (è nata a Lake Charles,
Louisiana, nel 1953) e al carattere rilassato e sornione che paiono portare in
dote; in parte, e secondo me nella parte sostanziale, la carriera di Lucinda è
stata sempre contrassegnata da un approccio assai incisivo alla sala d'incisione:
un lavoro - Fruits Of My Labor - di meticolosa, paziente e testarda professionalità
che, album dopo album, le ha consentito di cucirsi addosso un suono personalissimo
e immediatamente riconoscibile, quello poi estrinsecatosi in tre dischi - Car
Wheels On A Gravel Road, Essence), World Without Tears - a dir poco perfetti sotto
ogni possibile profilo. Non che quelli precedenti si segnalassero per demeriti
particolari, ma alla luce dell'inattaccabile equilibrio degli ultimi lavori è
naturale identificare i più stagionati Ramblin' ('78), Happy Woman Blues ('80),
Lucinda Williams ('89) e Sweet Old World ('92) nelle prove generali, talvolta
istintive e talvolta sofferte, di una visione che avrebbe trovato pieno compimento
soltanto in seguito. Logico, insomma, che giungesse il fatidico doppio dal vivo
a fotografare, celebrare e suggellare un lustro abbondante di ispirazione inesausta,
e Live @ The Fillmore non delude certo le aspettative, marchiando
anzi la stagione discografica in modo indelebile attraverso un trionfo di rabbia,
dolcezza, passione e rock'n'roll.
Merito ovviamente della statura di interprete
e di autrice archiviata da Lucinda, ma anche di una band che è la migliore che
si sia mai trovata alle spalle. Aggiungendo alla conta la spettacolare chitarra
solista di Doug Pettibone (un fenomeno o poco meno), il basso incalzante di Taras
Prodaniuk (attenzione al suo soliloquio su Are You Down) e il drumming quanto
mai duttile di Jim Christie (ora aggressivo e pestone, ora discreto e carezzevole),
sul palco ci sono in tutto quattro persone, eppure, all'occasione, sanno macinare
artiglieria rock come gli Stones al gran completo oppure creare un'atmosfera intima
e raccolta da folk-festival. La prima parte del doppio cd è affidata alle ballate
indolenti tra country, rock e blues che col tempo si sono trasformate nel tratto
distintivo della scrittura di Lucinda. Dal pigro laid-back di una splendida Out
Of Touch alle partiture jazzate della doppietta Overtime / Blue,
dal folk-rock struggente di Ventura alla filastrocca triste di Lonely
Girls, un magnifico catalogo della side of the road dove trovano rifugio
e disinfettante per le ferite vagabondi, solitari, uomini e donne in fuga o col
cuore spezzato, insomma tutti gli underdogs troppo romantici per integrarsi a
fondo nelle caselle della società. Il primo scossone arriva con l'abrasiva versione
di Changed The Locks, che dal punto di vista
del lavoro alla sei corde è il capolavoro assoluto di Pettibone, grezzo e richardsiano
(nel senso di "Keef") come non mai. Da qui in poi, e proseguendo in buona parte
del secondo disco, l'introspezione cede il timone a uno suono sporco, distorto,
quasi da garage band, con punte eclatanti di foga nella voce scorticata che accompagna
il ringhio di una sublime Joy (otto minuti
da brividi, con Lucinda recalcitrante e invelenita alla maniera di un Dan Stuart
in gonnella) e nell'epica alla Neil Young di una grandiosa Essence.
Ma tutta la parte centrale, che comprende pure il boogie-blues fiammeggiante
di Atonement, il drive granitico di I Lost It,
la sensualità di Righteously, una ruggente rilettura dell'ormai classica Pineola
e il rockaccio in odor di Paul Westerberg di Real Live Bleeding Fingers And
Broken Guitar Strings, è dominata dal fremito elettrico di un rock'n'roll
scomposto, nervoso, graffiante. Dopo il country-folk frizzante di Those
Three Days e il rapping allucinato di American Dream, la chiusa
dell'album torna a far quadrare il cerchio della malinconia e dei ricordi con
la rarefazione cinematica di World Without Tears, Bus
To Baton Rouge (in bellissima chiave semiacustica) e Words Fell.
Saluti di rito al pubblico con tre parole molto significative: "Love, peace &
revolution". A questo punto ignoro se, andandosene a Slidell, Lucinda Williams
sia riuscita a ritrovare la sua gioia. Quel che so è che si è dimostrata capace
di trasformare le proprie cicatrici, il proprio dolore e la propria femminilità
nella musica più autentica e coinvolgente - in una parola: bella - degli ultimi
quindici anni
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
 West [Lost Highway 2007]
West [Lost Highway 2007]
di Marco
Denti
 Si
sapeva ormai da tempo che Lucinda Williams viaggia ad altezze stratosferiche,
con un songwriting elementare ma dall'identità fortissima e con un'intepretazione
che, per forza, espressività e coraggio, non ha eguali. Era un po' più difficile
intuire che si sarebbe superata arrivando a forgiare un disco, West,
che va ben oltre l'intensa qualità di Essence e di World Without Tears e si sistema
tra il capolavoro Car Wheels On A Gravel Road (per l'intima natura delle canzoni)
e il Live @ The Fillmore (per l'energia profusa). In realtà, pur intrecciando
una moltitudine di connessioni con Essence (soprattutto nel trittico iniziale
di Are You Alright?, Mama You Sweet,
Learning How To Live), con le parti più elettriche
e rock'n'roll di World Without Tears (e di conseguenza del citato Live @ The Fillmore)
dove spiccano gli assist chitarristici di Doug Pettibone (splendidamente rumoroso
in Unsuffer Me, Come On e Wrap My Head
Around That) e naturalmente con Car Wheels On A Gravel Road, che è
e rimane il suo turning point, West fa classifica a sé. Questo perché Lucinda
Williams ci mette l'anima in ogni singola parola che canta, come se fosse una
questione di vita o di morte, come se il rock'n'roll non fosse destinato a rimanere
incastrato nelle sue ombre e nei suoi fallimenti, ma fosse una sorta di rituale
liberatorio. Si
sapeva ormai da tempo che Lucinda Williams viaggia ad altezze stratosferiche,
con un songwriting elementare ma dall'identità fortissima e con un'intepretazione
che, per forza, espressività e coraggio, non ha eguali. Era un po' più difficile
intuire che si sarebbe superata arrivando a forgiare un disco, West,
che va ben oltre l'intensa qualità di Essence e di World Without Tears e si sistema
tra il capolavoro Car Wheels On A Gravel Road (per l'intima natura delle canzoni)
e il Live @ The Fillmore (per l'energia profusa). In realtà, pur intrecciando
una moltitudine di connessioni con Essence (soprattutto nel trittico iniziale
di Are You Alright?, Mama You Sweet,
Learning How To Live), con le parti più elettriche
e rock'n'roll di World Without Tears (e di conseguenza del citato Live @ The Fillmore)
dove spiccano gli assist chitarristici di Doug Pettibone (splendidamente rumoroso
in Unsuffer Me, Come On e Wrap My Head
Around That) e naturalmente con Car Wheels On A Gravel Road, che è
e rimane il suo turning point, West fa classifica a sé. Questo perché Lucinda
Williams ci mette l'anima in ogni singola parola che canta, come se fosse una
questione di vita o di morte, come se il rock'n'roll non fosse destinato a rimanere
incastrato nelle sue ombre e nei suoi fallimenti, ma fosse una sorta di rituale
liberatorio.
West ne coglie tutta l'essenza, trovando posto per una malinconica
sezione d'archi (Where Is My Love?), per una
romanticissima fisarmonica (Words), per quel
mondo a parte che è la chitarra di Bill Frisell, il quale a pieno titolo fa parte
del piccolo e selezionatissimo team che ha seguito Lucinda Williams. Nomi scelti
sui rami migliori dell'albero genealogico del rock'n'roll: Jim Keltner è un'enciclopedia
vivente della batteria (basta ascoltare il tempo impossibile che detta in Rescue
per farsene un'idea), Tony Garnier è l'unico musicista ad aver resistito con Bob
Dylan così a lungo e questo, al di là delle inequivocabili doti di bassista, dovrebbe
bastare, Gary Louris ormai ha masticato abbastanza radici da permettersi qualcosa
in più e Hal Willner, che di West è il produttore, è un personaggio sì piuttosto
eccentrico ed evoluto, ma anche intelligente quanto basta per capire che un flusso
di emozioni si può accompagnare da una parte piuttosto che da un'altra, ma non
si può modificare più del tanto. Grande disco, grandissima Lucinda Williams.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
 Little Honey [Lost Highway 2008]
Little Honey [Lost Highway 2008]
di
Nicola Gervasini
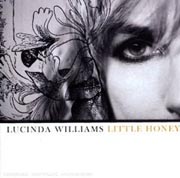 Pronti…partenza…via!.Riff...batteria…hey,
il basso! Dov'è il basso?...Stop!...ok, ripartiamo subito…di nuovo riff…batteria…basso…partiti!...vai
Lucinda, tocca a te: "ho trovato l'amore che cercavo stando dietro una chitarra
elettrica, è un amore vero, è un amore vero"…ecc...ecc... Ecco, questa è la cronaca
del primo minuto di Little Honey, e basterebbe per parlarne per
pagine e pagine. Lucinda Williams è tornata, e anche in fretta stavolta, con l'urgenza
di dire poche e semplici cose: che sta bene, che ha smesso di rimuginare sulle
proprie sofferenze e, soprattutto, che ha voglia di suonare tanto rock. Un messaggio
chiaro da quei primi versi di Real Love, dove
la soluzione di tutto era sempre stata lì, dietro una chitarra. Ma si poteva iniziare
benissimo dalla fine del disco per ricevere la stessa comunicazione, dalla cover
di It's A Long Way To The Top, un titolo che
nel 1975 per gli allora esordienti AC/DC suonava come una speranza (poi avveratasi)
di poter suonare rock and roll per una vita, ma che oggi appare quanto mai autobiografico
anche per lei, che al top, libera di fare rock and roll, ci è arrivata davvero
dopo una lunga strada. Se era apparso palese che West le fosse servito soprattutto
a svuotare l'anima da tutte le disperazioni, Little Honey arriva per riempirla
di nuovo con il campionario d'ordinanza di una musicista rootsy: tanto country
sempre (Well, Well, Well tira in ballo addirittura Charlie Louvin), ma
anche molto blues (Heaven Blues), gospel (la
lunga Rarity) e persino soul (Tears Of Joy
è una sorta di country-soul, la suadente Knowing sciorina una inaspettata
sezione fiati). Pronti…partenza…via!.Riff...batteria…hey,
il basso! Dov'è il basso?...Stop!...ok, ripartiamo subito…di nuovo riff…batteria…basso…partiti!...vai
Lucinda, tocca a te: "ho trovato l'amore che cercavo stando dietro una chitarra
elettrica, è un amore vero, è un amore vero"…ecc...ecc... Ecco, questa è la cronaca
del primo minuto di Little Honey, e basterebbe per parlarne per
pagine e pagine. Lucinda Williams è tornata, e anche in fretta stavolta, con l'urgenza
di dire poche e semplici cose: che sta bene, che ha smesso di rimuginare sulle
proprie sofferenze e, soprattutto, che ha voglia di suonare tanto rock. Un messaggio
chiaro da quei primi versi di Real Love, dove
la soluzione di tutto era sempre stata lì, dietro una chitarra. Ma si poteva iniziare
benissimo dalla fine del disco per ricevere la stessa comunicazione, dalla cover
di It's A Long Way To The Top, un titolo che
nel 1975 per gli allora esordienti AC/DC suonava come una speranza (poi avveratasi)
di poter suonare rock and roll per una vita, ma che oggi appare quanto mai autobiografico
anche per lei, che al top, libera di fare rock and roll, ci è arrivata davvero
dopo una lunga strada. Se era apparso palese che West le fosse servito soprattutto
a svuotare l'anima da tutte le disperazioni, Little Honey arriva per riempirla
di nuovo con il campionario d'ordinanza di una musicista rootsy: tanto country
sempre (Well, Well, Well tira in ballo addirittura Charlie Louvin), ma
anche molto blues (Heaven Blues), gospel (la
lunga Rarity) e persino soul (Tears Of Joy
è una sorta di country-soul, la suadente Knowing sciorina una inaspettata
sezione fiati).
Stili, idee, suoni prima ancora che canzoni, è questa
la grande novità portata da Little Honey nella carriera di Lucinda Williams, un
disco nato per essere suonato prima ancora che ascoltato, dove la chitarra di
Doug Pettibone è libera di essere protagonista indiscussa e di toglierle spazio
in Honey Bee, e la sezione ritmica David Sutton
e Butch Norton pompa ritmo pestando selvaggiamente come sul palco. Ed è anche
il suo primo disco auto-celebrativo, evidente in quell' omaggiare la sé stessa
che fu recuperando schegge impazzite perse nel tempo (la strascicata Circles
and X's è del 1985), oppure lasciando che un mostro sacro come Elvis Costello
incasini la melodia di Jailhouse Tears per
glorificare la propria ammissione nel gotha del rock che conta. E in questo turbine
di esercizi di stile, persino le sue tipiche ballate struggenti (Little Rock
Star, If Wishes Were Horses e l'acustica e bellissima Plan
To Marry) acquisiscono una insolita leggerezza. Little Honey non sarà
mai ricordato come uno dei suoi dischi più rappresentativi, non ha lo spessore
dei suoi predecessori e ne conserva persino alcuni difetti (ad esempio l'eccessiva
prolissità), ma è il disco dove per la prima volta Lucinda non si atteggia a fare
la rocker vissuta e non ostenta più le proprie cicatrici, ma fa semplicemente
la rock-singer. E un disco così non serviva solo a lei.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
 Blessed [Lost Highway / Universal 2011]
Blessed [Lost Highway / Universal 2011]
di
Marco Denti
 Ispiratissima,
concentrata, con un sound levigato quel tanto che basta a dare i giusti contorni
alle canzoni ma suonato come se fosse dal vivo, Lucinda Williams sfodera un disco
che è l'apoteosi del suo songwriting, delle sue capacità di performer e della
sua splendida, innata indole rock'n'roll. Il termine di paragone più vicino è,
senza esitazioni, il suo capolavoro, Car Wheels On Gravel Road: Blessed
è meno istintivo e più ragionato, cede qualcosa alla freschezza (ed è anche inevitabile,
visti gli anni e i dischi consumati da Lucinda Williams) e ne guadagna in maturità.
Soprattutto ne guadagna il suo suono, sospeso sempre tra le ballate rarefatte
e le spettacolari incursioni in uno dei rock'n'roll più elettrici degli ultimi
anni, ne ha guadagnato. Va detto che alla solida coppia di produttori che già
l'aveva seguita per Little Honey, ovvero Eric Liljestrand e Tom Overby, si è aggiunto
Don Was e gli effetti si sentono soprattutto in termini di omogeneità e di impatto
sonoro. Persino l'invitato di turno, Elvis Costello, che qui rende il favore a
Lucinda Williams per il duetto su The Delivery Man sembra un altro. La sua chitarra
(insieme ad altre due o tre, per inciso) rende Seeing
Black una meravigliosa cavalcata elettrica e il fatto che sia messa
lì, nel cuore di Blessed, non deve essere un caso. Ispiratissima,
concentrata, con un sound levigato quel tanto che basta a dare i giusti contorni
alle canzoni ma suonato come se fosse dal vivo, Lucinda Williams sfodera un disco
che è l'apoteosi del suo songwriting, delle sue capacità di performer e della
sua splendida, innata indole rock'n'roll. Il termine di paragone più vicino è,
senza esitazioni, il suo capolavoro, Car Wheels On Gravel Road: Blessed
è meno istintivo e più ragionato, cede qualcosa alla freschezza (ed è anche inevitabile,
visti gli anni e i dischi consumati da Lucinda Williams) e ne guadagna in maturità.
Soprattutto ne guadagna il suo suono, sospeso sempre tra le ballate rarefatte
e le spettacolari incursioni in uno dei rock'n'roll più elettrici degli ultimi
anni, ne ha guadagnato. Va detto che alla solida coppia di produttori che già
l'aveva seguita per Little Honey, ovvero Eric Liljestrand e Tom Overby, si è aggiunto
Don Was e gli effetti si sentono soprattutto in termini di omogeneità e di impatto
sonoro. Persino l'invitato di turno, Elvis Costello, che qui rende il favore a
Lucinda Williams per il duetto su The Delivery Man sembra un altro. La sua chitarra
(insieme ad altre due o tre, per inciso) rende Seeing
Black una meravigliosa cavalcata elettrica e il fatto che sia messa
lì, nel cuore di Blessed, non deve essere un caso.
Attorno a Seeing Black,
si coagulano anche Soldier's Song, una ballata
strepitosa che racconta questi anni di guerra come nessun altro ha fatto, e la
stessa Blessed che in sé è la migliore carta d'identità di Lucinda Williams. Non
ci importa il gossip (c'è fin troppa gente che se ne occupa), ma in tutta evidenza
il recente matrimonio ha giovato alle condizioni in cui scaturisce il suo songwriting:
a parte Seeing Black, Soldier's Song e forse Ugly Truth, la Lucinda Williams
di Blessed è un'appassionata, convinta e particolarissima interprete degli "inarticolati
linguaggi del cuore", per dirla con Van Morrison. Sa di cosa sta parlando quando
si parla d'amore (e qui, invece, per citare Raymond Carver, uno che non è molto
distante dalle sue visioni): To Be Loved, Sweet
Love, Kiss Like Your Kiss celebrano
l'amore a tutto tondo, che poi non è riferito soltanto ai legami con un'altra
persona, ma è tout court un modo di affrontare la vita. Basta sentire Buttercup
(non è difficile, è la prima del disco) per capire che Lucinda Williams ama gli
Stones, così come tutti quei musicisti il cui nome scompare spesso nelle note
a piè di pagina, ma che sanno dare sempre un contributo superiore. In Blessed
ci sono, tra gli altri, Matthew Sweet alle voci, Rami Jaffe alle tastiere e l'onnipresente
Greg Leisz alle chitarre che, con tutta l'attenzione alle canzoni di Lucinda Williams,
diffondono raffinatezze a piene mani. Di più, non si può chiedere, ma per gli
eterni insoddisfatti, la versione speciale di Blessed contiene anche un altro
disco, The Kitchen Tapes, che ritare Lucinda Williams sola con la sua chitarra
e le sue (e altre ancora) canzoni. Tra i dischi dell'anno, già da adesso.
|